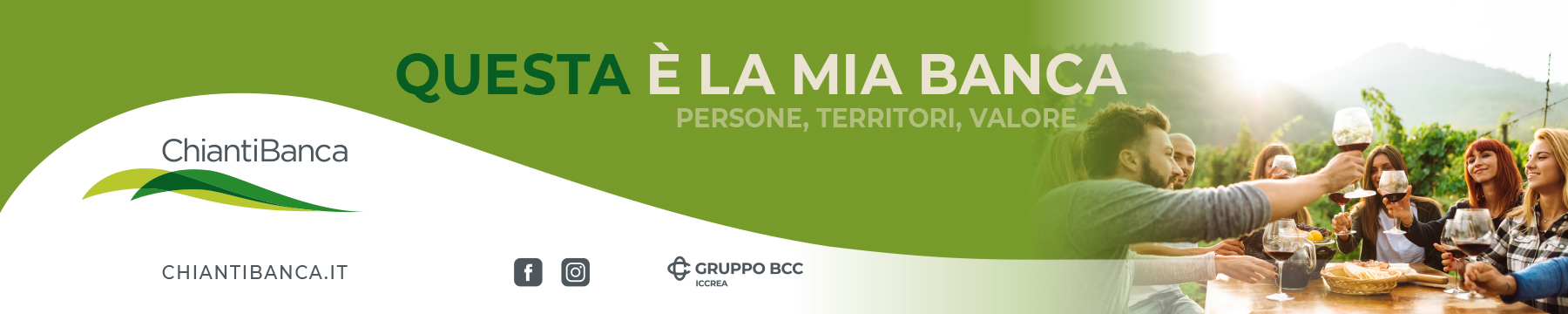Adv
Il rogo del Ballarin e la lezione che ha cambiato la sicurezza negli stadi

Il delicato tema della sicurezza negli stadi: come si è evoluta la normativa dopo i fatti di cronaca degli anni Ottanta
Ci sono giornate che segnano la storia di uno sport non per i gol, non per le vittorie, ma per le lacrime. Il 7 giugno 1981, a San Benedetto del Tronto, non fu solo il giorno della promozione in Serie B della Sambenedettese. Fu il giorno in cui lo stadio Ballarin divenne teatro di una tragedia che lasciò un segno profondo nel cuore dei tifosi e, nel tempo, anche nella normativa italiana sulla sicurezza negli stadi.
Il contesto: Sambenedettese – Matera, 1981
Era l’ultima giornata del campionato di Serie C1. Bastava un pareggio alla Sambenedettese per conquistare la promozione in Serie B. Lo stadio Ballarin era gremito oltre ogni limite. La partita doveva essere una festa, ma divenne un inferno. Prima del fischio d’inizio, nel settore Distinti – tradizionalmente dedicato alle donne e ai bambini – vennero accesi alcuni fumogeni per dare il via ai festeggiamenti. Ma qualcosa andò storto.
Un telo appeso sulle balaustre prese fuoco e, alimentato dal vento, scatenò un rogo violentissimo. Le fiamme divorarono il settore, e la folla impazzita tentò di fuggire, ma le uscite erano chiuse. La calca si fece mortale.
Il bilancio fu drammatico: due ragazze, Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri, morirono bruciate vive. Oltre 60 furono i feriti, molti in modo gravissimo.
Il vuoto normativo e la svolta necessaria
All’epoca, la normativa sulla sicurezza negli stadi era pressoché inesistente. Mancava un piano strutturato di evacuazione, le uscite di sicurezza non erano adeguate, e l’uso dei materiali altamente infiammabili – come striscioni e teli – era all’ordine del giorno. L’incendio del Ballarin fu un segnale di allarme ignorato per troppo tempo, ma che negli anni successivi avrebbe spinto il legislatore a intervenire.
Fu solo dopo ulteriori tragedie (Heysel, Torino nel 1983, e successivamente Hillsborough nel 1989) che si impose l’urgenza di normare in modo stringente la sicurezza negli impianti sportivi.
Verso una normativa moderna: prevenzione antincendio e gestione delle folle
Negli anni ’90, e con particolare spinta dopo il 2001, vennero introdotti obblighi tecnici e progettuali stringenti per gli stadi, culminati nel D.M. 18 marzo 1996, che definisce le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi. Tra i punti più rilevanti:
- Obbligo di uscite di sicurezza libere e accessibili;
- Sistemi di evacuazione efficaci;
- Divieto di materiali infiammabili in prossimità del pubblico;
- Formazione del personale addetto alla sicurezza;
- Controlli più rigidi sui flussi d’ingresso e uscita.
In parallelo, anche il concetto di gestione delle folle è evoluto, prevedendo la divisione per settori, l’eliminazione delle barriere fisiche troppo rigide e l’adozione di sistemi di monitoraggio in tempo reale.
Riflessioni finali: la memoria che insegna
Oggi lo stadio Ballarin non esiste più, ma la sua storia continua a insegnare. Le voci dei superstiti, come riportato in numerose testimonianze , raccontano di un tempo in cui la passione superava la prudenza. Oggi, grazie anche a quelle ferite, possiamo dire che il calcio italiano ha fatto passi avanti significativi nella sicurezza.
Ma ogni lezione, per essere viva, va ricordata. E il ricordo del Ballarin non può essere solo commemorazione: deve essere impegno, affinché la festa del calcio resti sempre tale.